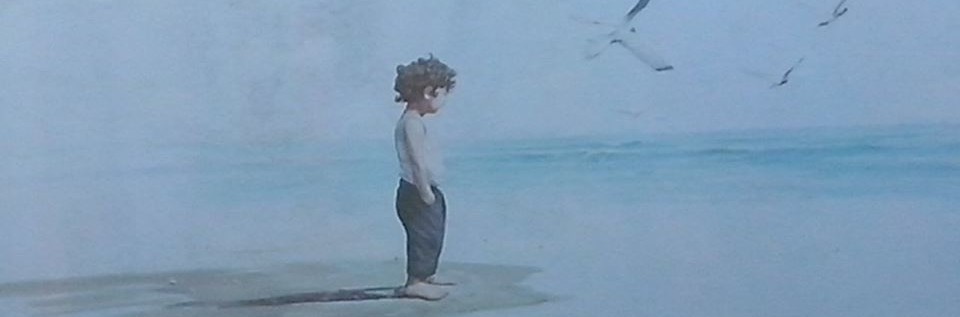di Omar Battisti
Un termine superato?
Perché parlare ancora di nevrosi infantile? Cosa ha ancora da dire questo riferimento fondamentale della psicoanalisi nella nostra attualità? Non è forse ormai superato e inattuale, visto quanto viene portato avanti a partire dalla scienza e dal mercato? Anzitutto c’è da dire come la nevrosi infantile indichi un rapporto del bambino con il linguaggio e con i suoi simili, dove il gioco è un’attività fondamentale in quanto spazio costituente per il soggetto. Quando nella vita del bambino emerge qualcosa di nuovo, come ad esempio nel piccolo Hans la nascita della sorellina o la prima erezione, un sintomo può sancire quest’emergenza vitale che altera la possibilità di dar luogo all’apprendimento secondo la logica classica di ogni educazione. È a questo punto che il discorso analitico può dare un’altra risposta, servendosi proprio dello spazio del gioco, a ciò che non va nel bambino. In questo modo: considerando il suo sapere come qualcosa di autentico e frutto del lavoro di un soggetto in pieno esercizio. Dunque non un piccolo adulto che dovrà attraversare determinate fasi di apprendimento per arrivare ad una maturità, ma un soggetto già alle prese con le questioni essenziali con cui ha a che fare ogni essere parlante, ovvero sostanzialmente: Da dove vengo? Perché sono nato? Sono maschio o sono femmina? Domande che nella nevrosi infantile si manifestano con il sintomo. Il piccolo Hans non a caso inizia ad avere delle difficoltà particolari proprio quando incontra qualcosa che lo riporta alle questioni sopra poste: la nascita della sorella e la prima erezione.
Quello che non si apprende.
È molto diverso pensare di insegnare al bambino come padroneggiare un organo che si sviluppa secondo certe leggi (il linguaggio è così inteso come una parte del corpo che si svilupperà e maturerà col tempo), piuttosto che accompagnare, sostenere e interrogare il suo prendere la parola.
Il linguaggio non si apprende.
Jakobson si interroga sul come si sviluppa e si deteriora il linguaggio. Secondo lui ciò avviene come lo sviluppo e il deterioramento di un organo, seguendo certe regolarità costanti. Quali sono gli strumenti usati per una tale analisi? Il suono viene sminuzzato in una griglia di elementi caratteristici, isolati e isolabili, considerati come cellule del corpo della lingua: i fonemi, a loro volta sezionate in base a un sistema di catalogazione funzionante come un microscopio che permette di differenziare elementi microscopici, o meglio microfonici trattandosi di suono, ad esempio distinguendo tra liquide, dentali e palato-velari, ecc… fondate su una opposizione tipo aperto-chiuso.
Quindi pensa ad esempio l’afasia come non riducibile a disturbi di ordine meccanico-articolatorio nella capacità di usare correttamente i muscoli legati alla produzione di suoni. Per lui è in gioco la funzione segnica. Tuttavia in questo passaggio si può rintracciare un punto di divergenza rispetto al discorso analitico:
Recentemente la sveglia ha interrotto un mio sonno in cui sognavo di aver detto seme, e una volta svegliato sono stato sicuro che questo stava per zemrel “morto” (generalmente adesso sogno in ceco) […] mutezza del suono: le liquide sono cadute, e le consonanti sonore, come è comune negli afasici, hanno perso la loro sonorità[1].
Eleggere un significante a padrone
Il passaggio da seme a zemrle è letto esclusivamente riducendo a leggi foniche, non viene data nessuna portata alla verità e a ciò che di reale può essere in gioco in questa trasformazione. Il bambino entra nel linguaggio a partire da suoni, dal non senso. Dunque si considera primario il versante di suono slegato dal senso, cosa ben presente anche nell’analisi di Jakobson dove tuttavia non viene dato alcun rilievo a quello che in questa trasformazione prende corpo: una verità e un reale che così passa dalla lalingua ad un significante eletto come padrone. Questa elezione sancisce il rimando necessario ad un luogo dove può compiersi l’operazione stessa di un tale passaggio: l’elezione di un significante principale comporta che il bambino entra nel legame sociale; altro modo di nominare il fatto che qualcosa della funzione materna viene ceduto, ed un significante oblitera questa cessione.
Un battito in due tempi
L’entrata nel linguaggio può essere interrogata anche sul versante del tempo logico come distinto tra durata e istante. Se l’entrata rimanda ad una soglia da passare secondo il tempo dell’istante, tuttavia questo non può accadere prescindendo dalla dimensione della durata. Questa dimensione temporale trovo venga presa in conto essenzialmente da Freud nel suo Caso clinico dell’Uomo dei lupi, dove tra l’altro si riferisce in modo marcato al Nachtraglichkeit, ciò che riprenderà poi Lacan con l’apres-coup e direi anche con il tempo logico. Questo rimando di Freud al tempo è già presente in questa frase: “a un anno e mezzo egli raccolse le impressioni la cui comprensione differita fu poi resa possibile dal suo sviluppo dell’eccitamento sessuale, dall’esplorazione sessuale infantile”[2]. Anzitutto Freud rileva che qualcosa a un anno e mezzo ha segnato il soggetto ma solo più tardi ha prodotto i suoi effetti, grazie all’esplorazione sessuale infantile, che può costituire un altro modo di considerare il linguaggio infantile, alla luce della pulsione. L’effetto differito di quanto colpisce in un primo tempo è anche ciò che Freud sostiene tenacemente contro la posizione di Jung che considera le reminiscenze infantili e le fantasie infantili dei nevrotici come simboli infantili che distolgono l’adulto da compiti della realtà che non vuole affrontare. Freud al contrario considera che queste fantasie e reminiscenze agiscano in due tempi, riconoscendovi “l’influsso progressivo”[3] delle nevrosi infantili.
Le reminiscenze infantili non sono simboli infantili che distolgono l’adulto dai suoi compiti nella realtà, ma agiscono in modo propulsivo attraverso il trasferimento della libido che diventa mobile e può spostarsi da un elemento ad un altro. “L’influsso dell’infanzia si fa sentire già nello stadio iniziale della formazione della nevrosi poiché concorre in modo decisivo a determinare se e in qual punto l’individuo subirà uno scacco nel tentativo di padroneggiare i problemi reali della sua esistenza”[4], “in questo caso non scopriamo altro che moti pulsionali che il bambino non riesce a soddisfare e che non è abbastanza grande per padroneggiare”[5]. Con Lacan si può considerare che questo passaggio di Freud non è da leggere in senso diacronico, come stadi di sviluppo, ma, permette di leggere la rimozione come un battito in due tempi, entrambe necessari: una traccia si deve iscrivere per poi essere cancellata. Operazione questa che tocca il corpo del bambino, nel suo incontro con lalingua.
Ritorno sul linguaggio.
Si può dire che il bambino entra nel linguaggio ad opera della cancellazione del colpo che segna l’incontro tra corpo e godimento.
Questo è radicalmente diverso dal sostenere che il linguaggio è un organo che cresce come altri organi del corpo e che si sviluppa secondo delle leggi strutturali interne così come il cuore, il fegato, le mani. Per cui il bambino apprenderebbe il linguaggio a partire da quelle leggi interne che si dispiegano come un fiore che sboccia dal ramo, secondo una tesi classica sostenuta tra altri anche da Chomsky quando afferma: l’organo crea la funzione. Tesi che Lacan riprende e sovverte nel Capitolo II del Seminario XXIII, Di ciò che fa buco nel reale (pagina 29 e 30) quando dice: “E’ con questa funzione del buco che il linguaggio opera la sua presa sul reale”. Dunque: come il linguaggio tratta il reale? Grazie al buco.
Rimozione, buco.
Dal testo di Miller, Il bambino tra madre e donna[6] comunicazione fatto nel contesto del primo convegno svizzero della scuola europea di psicoanalisi organizzato a Losanna l’1 e 2 giugno 1996 dal Circolo di Ginevra e dal Circolo di Losanna, estrapolo questi punti:
-il giusto posto dell’oggetto è quello in relazione alla castrazione, ovvero la mancanza è indispensabile.
-se il bambino è equivalente fallico, non solo colma ma divide la madre, tra madre e donna.
-l’amore materno rende il bambino non un equivalente del fallo ma un oggetto feticcio, se questo amore non lascia spazio al desiderio femminile, per sua natura non-tutto
-la presenza del bambino può angosciare il padre in quanto lo confronta con il non-tutto del desiderio femminile, con l’enigma del desiderio dell’Altro
-per umanizzare il desiderio di bambino un padre ha da acconsentire al non-tutto del desiderio femminile, altrimenti riduce nel bambino il soggetto all’Altro del sapere, all’Altro della domanda.
Il risultato di una disciplina di ogni istante
Una citazione finale dalla “Lettere chiara come il sole” del 9 settembre 2001 di Miller:
«No, la psicoanalisi non insegna affatto che l’adulto ha sempre ragione. Solo i farisei lo credono. Non basta dire che Lucile dovrà abbandonare il Lustprinzip per il principio di realtà, e che quando la sostituzione sarà fatta, saprà, come voi e me, che un buco è un buco è un buco. Resta, charmante Lucile, resta l’essere di desiderio che sei stata per tutta l’estate, e regnerai suoi cuori!
Le lacrime di
Lucile mi hanno interpretato. Hanno interpretato nel mio enunciato la presenza
di un desiderio, un desiderio cattivo, segnalato da Freud, che ho analizzato,
ma che tuttavia riappare di tanto in tanto subdolamente in quel che dico senza
pensarci. La lezione ricevuta da Lucile senza dubbio vale un regalo. Lacan era
qualcuno del tipo di Lucile. Come lei vi ascoltava e rispondeva “al livello del
desiderio”. E’, nel caso di Lucile, l’effetto del genio dei suoi tre anni. Era,
nel caso di Lacan, il risultato di una disciplina di ogni istante»
[1] R. Jakobson, Linguaggio infantile e afasia, Einaudi, Torino 2006, pag. 64.
[2] S. Freud, Casi clinici n°7, L’uomo dei lupi, Boringhieri, Torino 1997, pag. 44, nota 4.
[3] Ibidem, pag. 49.
[4] Ibidem, pag. 60.
[5] Ibidem, pag. 61.
[6] J.-A. Miller, Il bambino tra madre e donna, Filum, n.14.